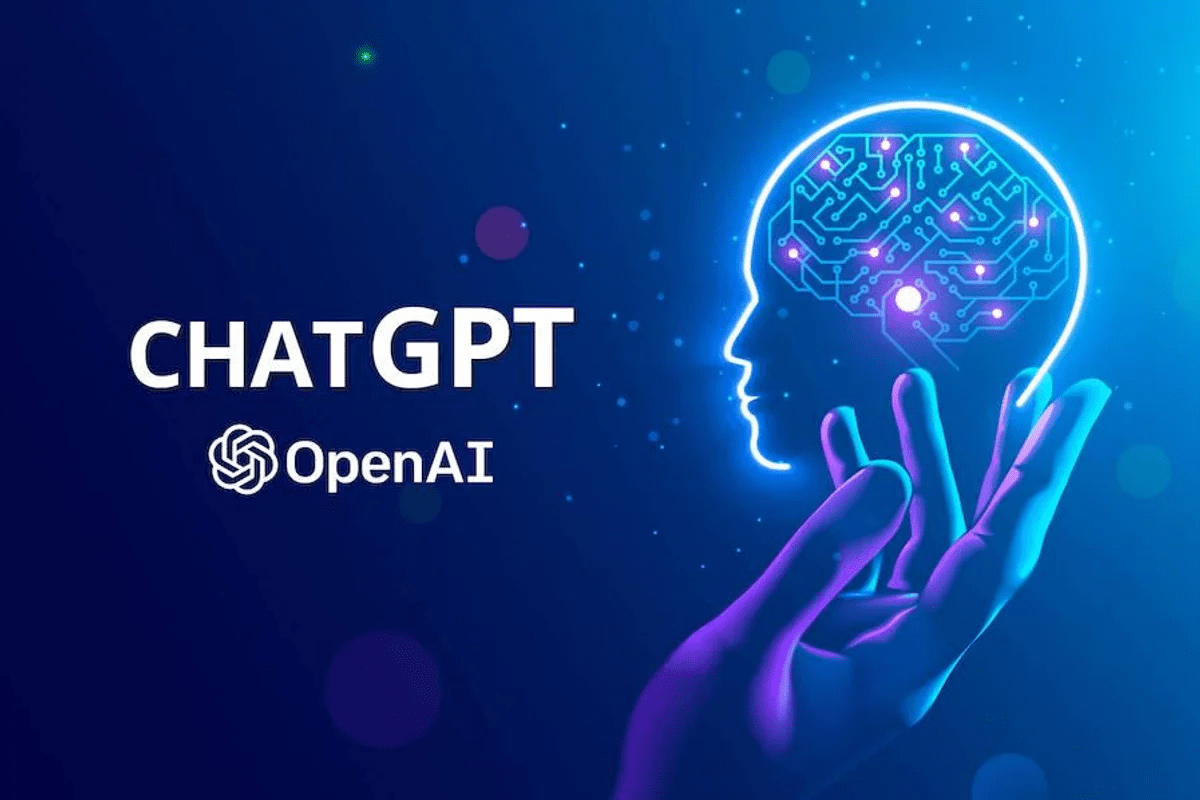Uno dei problemi più urgenti per la Scuola italiana, per gli Istituti superiori, è certamente quello dell’orientamento scolastico e professionale. Il D.M. n.328 del 22 dicembre 2022 ha indicato le linee guida per avviare una “riforma del sistema di orientamento” nell’ambito della Missione 4 - Componente 1 - del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.).
Nel 2023 sono state emanate ben sette circolare attuative che hanno delineato ed indicato le modalità operative per definire la figura dell’orientatore e del tutor scolastico.